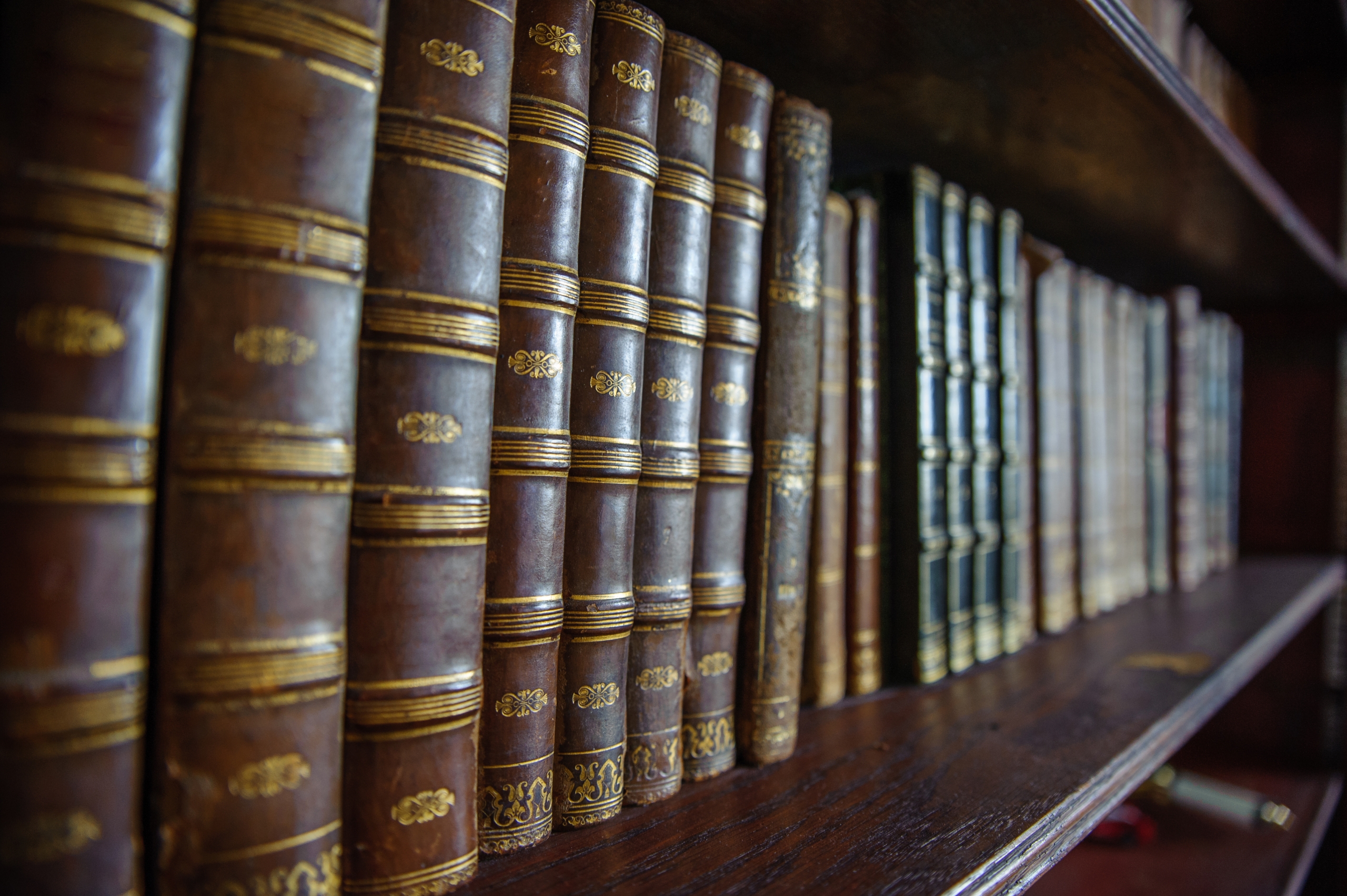Le comunità musulmane in Ticino tra diversità, invisibilità e partecipazione sociale

Nell’ottica di un rafforzamento della coesione sociale, responsabilità comune di istituzioni e società civile, è fondamentale disporre di informazioni fattuali e conoscenze scientifiche sulla diversità religiosa e culturale locale. Per il contesto ticinese, un contributo determinante alla comprensione di questa tematica complessa è stato fornito dalla ricerca “Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino”, promossa dal Dipartimento delle istituzioni del Cantone e realizzata dal Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC). Lo studio ha analizzato le caratteristiche delle comunità religiose, mettendo in luce l’importante diversità tra le tradizioni presenti in Ticino e al loro interno. La ricerca ha evidenziato la crescente diversificazione del paesaggio religioso cantonale e la vitalità che lo contraddistingue, in termini di pratiche religiose, pluralità linguistica e attività socio-culturali. Non da ultimo, ha approfondito la distribuzione dei luoghi di culto sul territorio – documentata anche tramite una mappa interattiva – e le dinamiche di visibilità e accesso allo spazio, spesso tra le sfide principali affrontate dalle comunità censite.
Le comunità religiose musulmane in Ticino si inseriscono in questo contesto dinamico e diversificato. Appoggiandosi ai risultati della ricerca Re:Spiri, il presente articolo delinea la loro presenza nel Cantone, descrive i luoghi di culto islamici e approfondisce le dinamiche di accesso allo spazio. In conclusione, il contributo traccia un parallelo tra l’invisibilità architettonica di questi luoghi e il limitato riconoscimento delle comunità musulmane come parte integrante della società ticinese.
Una presenza pluridecennale nel Cantone
Nel 2024, la ricerca Re:Spiri ha repertoriato la presenza di nove comunità musulmane in Ticino, che si distinguono in otto comunità sunnite e una comunità sciita e rappresentano l’1,8% delle 503 comunità religiose repertoriate. L’istituzione delle comunità religiose musulmane riflette la progressiva diversificazione del paesaggio religioso nazionale e cantonale. In Ticino, tale processo si sviluppa in più fasi inizialmente all’interno del cristianesimo, con la fondazione – a partire dal XIX secolo – della Chiesa cattolica cristiana, delle Chiese evangeliche riformate e della Chiesa anglicana. Nei primi decenni del XX secolo la diversificazione si estende anche al di fuori del cristianesimo, con la nascita della Società teosofica (esoterismo) e della Comunità israelita di Lugano (ebraismo). Tuttavia, la diversità religiosa cantonale aumenta significativamente a partire dagli anni Sessanta del XX secolo, a seguito dei vari movimenti migratori e degli effetti della globalizzazione. In questo periodo nascono le prime comunità bahá’í, emergono le comunità buddiste e i nuovi movimenti religiosi, e si moltiplicano le presenze di correnti religiose cristiane quali il protestantesimo evangelico, il millenarismo cristiano, il cristianesimo ortodosso e il cristianesimo orientale[1].
La ricerca Re:Spiri evidenzia che le prime comunità musulmane in Ticino si costituiscono formalmente come associazioni negli anni Novanta. L’Associazione Islamica Turco-Svizzera, fondata nel 1989, inizia le proprie attività in un luogo di culto nel Grigioni italiano, per poi trasferirsi stabilmente in Ticino all’inizio del XXI secolo. Nel 1991 nasce la Comunità Islamica nel Cantone Ticino e nel 1999 l’Associazione Islam Senza Frontiere. Tra il 2002 e il 2009 si assiste alla costituzione di quattro comunità musulmane sunnite: il Centro Culturale Turco Islamico di Lugano, il Centro Culturale Islamico Albanese Lugano, la Lega dei Musulmani in Ticino e l’Associazione Culturale Islamica del Mendrisiotto. L’unica comunità sciita presente nel cantone è il Centro Culturale Imam Ali del Ticino, creato nel 2004. Più recente, risalente ad alcuni anni fa, è invece la fondazione dell’Associazione Džemat Ticino[2].
In Ticino, a partire dagli anni Novanta del XX secolo assistiamo quindi alla creazione di strutture associative e alla costituzione delle prime comunità religiose islamiche, segno di una presenza musulmana già consolidata nel Cantone. In effetti, facendo riferimento ai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) riguardanti le appartenenze religiose individuali, è possibile osservare che se nel 1970 lo 0,1% della popolazione residente nel cantone si definiva musulmana, questa percentuale è aumentata nei decenni successivi, in particolare tra il 1990 e il 2000, passando dallo 0,5% all’1,5%. Nel 2010 la popolazione musulmana in Ticino rappresentava circa l’1,8% del totale, mantenendosi stabile negli anni successivi. Nel 2023, la percentuale di persone musulmane in Ticino è pari al 2,2%, a fronte di una percentuale del 6% a livello nazionale. Secondo questi dati – che si riferiscono alla popolazione residente permanente di età superiore ai 15 anni e che poco ci dicono sulla frequenza delle pratiche religiose e altri aspetti della religiosità – nel 2023 in Ticino vivono circa 6’800 persone che si definiscono musulmane (UST, 2025).
Luoghi di culto invisibili in città
Tra i risultati centrali della Cartografia Re:Spiri, l’analisi della tipologia dei luoghi di culto ha permesso di interpretare il territorio attraverso la lente dell’(in)visibilità di questi spazi. I luoghi di culto delle nove comunità musulmane presenti nel Cantone si concentrano nelle aree urbane di Chiasso (tre comunità), Lugano (quattro comunità) e Bellinzona, dove due comunità condividono lo stesso spazio[3]. Tuttavia, nonostante questa apparente centralità e la presenza pluridecennale delle comunità musulmane in Ticino, la ricerca di luoghi adatti ad ospitare la propria comunità rimane una sfida comune.
Gli attuali luoghi di culto islamici sono difficilmente riconoscibili in quanto tali e spesso situati in zone industriali e periferiche rispetto ai centri urbani. La realtà che in tedesco viene definita con il termine alquanto evocativo di Hinterhof-Moschee – traducibile in italiano come moschea nel cortile interno o moschea nascosta – è riscontrabile anche in Ticino, dove la totalità delle comunità musulmane, analogamente a circa settanta altri gruppi religiosi presenti nel Cantone, si riunisce in luoghi riadattati per lo svolgimento delle pratiche religiose, originariamente non concepiti né costruiti per scopi religiosi. Si tratta perlopiù di ex locali commerciali o appartamenti, spesso situati al piano terra di stabili residenziali. Agli occhi dei più, questi luoghi adibiti successivamente alla pratica religiosa rimangono invisibili.

Il Centro islamico di Bellinzona, inaugurato il 27 settembre 2025, visto dall’esterno (I). Foto: Luan Afmataj, 2025

Il Centro islamico di Bellinzona, inaugurato il 27 settembre 2025, visto dall’esterno (II). Foto: Luan Afmataj, 2025
L’accesso allo spazio non è determinato solo da questioni di (in)visibilità, ma anche dalle modalità di occupazione dei luoghi, di cui le comunità possono essere proprietarie, affittuarie, subaffittuarie o beneficiarie. I risultati di Re:Spiri mostrano che le comunità non cristiane e quelle di più recente fondazione all’interno del cristianesimo sono generalmente in affitto o usufruiscono gratuitamente del luogo di culto. Al contrario, esse sono più raramente proprietarie dello stesso rispetto a comunità cattoliche romane, evangeliche riformate o cattoliche cristiane. In Ticino, solo un luogo di culto islamico è di proprietà. Questa precarietà di accesso allo spazio interessa quindi la maggior parte delle comunità musulmane, che sottolineano l’assenza di spazi adeguati per la pratica religiosa e l’onerosità dei costi di affitto tra le sfide principali che le riguardano.
Tra invisibilità architettonica dei luoghi e invisibilità del ruolo sociale delle comunità
L’invisibilità architettonica delle moschee si riflette in dinamiche di ordine sociale, sollevando questioni di inclusione e coesione. In Ticino come in Svizzera, la partecipazione sociale delle comunità musulmane e la loro diversità emergono solo marginalmente nel dibattito pubblico. Vari studi mostrano che le persone e le comunità musulmane sono spesso rappresentate come un problema da risolvere. Nei discorsi politici e mediatici appaiono soprattutto in relazione a temi di radicalizzazione o presunta mancata integrazione (Trucco, Dehbi, Dziri, Schmid, 2025, 16-22). Una tale immagine, basata su meccanismi di esclusione e riduttiva della complessità, è messa in discussione dai dati sociologici presentati.
La ricerca Re:Spiri mette infatti in luce numerosi aspetti della diversità e del ruolo sociale delle comunità musulmane. Ad esempio, le lingue utilizzate per la pratica religiosa sono l’italiano – parlato in tutte le comunità – nonché l’arabo, il turco, l’albanese, il bosniaco, il farsi e l’urdu. La dimensione della diversità linguistica si intreccia inoltre con le molteplici attività socio-culturali svolte. Tra queste si annoverano corsi di lingua italiana e di lingua d’origine, lezioni di arabo e momenti di lettura del Corano. Numerose comunità propongono inoltre conferenze, corsi di insegnamento religioso, programmi di doposcuola, ma anche attività ricreative come escursioni e giornate di socializzazione. Le comunità celebrano feste tradizionali e partecipano attivamente a eventi interculturali e interreligiosi, oltre che ad attività promosse da enti pubblici, come la Festa dei Popoli di Locarno. Durante il mese di Ramadan si stanno affermando momenti condivisi per la rottura del digiuno (Iftar) svolti in ampi spazi e aperti alla popolazione. Tali iniziative evidenziano con chiarezza la diversità delle comunità musulmane e il loro contributo alla società ticinese, aspetti che, analogamente all’invisibilità dei luoghi di culto, sono ancora poco riconosciuti.

Gli interni del nuovo Centro islamico di Bellinzona, condiviso da due associazioni musulmane del Sopraceneri (I). Foto: Luan Afmataj, 2025
Prospettive di approfondimento e collaborazione
Attive da decenni nel Cantone, le comunità musulmane sono caratterizzate da diversità interna e dinamismo, visibili non solo nelle pratiche religiose, ma anche nella varietà linguistica e nelle attività socio-culturali proposte. Il presente contributo ha offerto una panoramica delle comunità sulla base di dati quantitativi esposti in una ricerca centrale per il Ticino[4]. Gli elementi emersi suggeriscono una pluralità analoga alle realtà di altri Cantoni, che andrebbe ulteriormente analizzata attraverso dati qualitativi che permettano di esplorare più a fondo la diversità dei percorsi individuali e ulteriori specificità delle comunità musulmane in Ticino. Pur partecipando attivamente e contribuendo significativamente alla coesione sociale, le comunità musulmane rimangono in gran parte invisibili sul piano architettonico e poco riconosciute sul piano sociale. In questo contesto si rende necessaria una riflessione critica da parte delle istituzioni sul percorso da intraprendere per contrastare gli ostacoli che limitano un’equa partecipazione e riducono la visibilità del contributo delle comunità musulmane alla società ticinese. A tal fine, è fondamentale promuovere legami di fiducia e rafforzare la collaborazione con le associazioni musulmane, per rispondere ai bisogni espressi, dialogare alla ricerca di soluzioni condivise e affrontare insieme le sfide future.
[1] Cfr. Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Per maggiori informazioni sulle tradizioni e correnti religiose presenti in Ticino, si veda il glossario sviluppato dal Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC), presente sul sito internet Geo-religions.ch: https://geo-religions.ch/it/panoramica-di-tutte-le-comunita-religiose-e-spirituali/, consultazione 04.09.2025.
[2] Tutte le comunità musulmane attualmente attive in Ticino sono organizzate sotto forma di associazioni e soggette al diritto privato. Nel cantone, solo la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute in quanto corporazioni di diritto pubblico, secondo l’articolo 24 della Costituzione cantonale. Il secondo capoverso del medesimo articolo non esclude la possibilità di attribuire la “personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose”; tuttavia, la legislazione cantonale non fornisce indicazioni precise su come tale procedura debba essere applicata nella pratica (Moretti, Roveri, 2024: 36–39).
[3] Cfr. la carta interattiva della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino, accessibile sul sito internet Geo-religions.ch, realizzato dal Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC). https://geo-religions.ch/it/, consultazione 26.05.2025.
[4] Cfr. Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino. Annuario di Storia Religiosa della Svizzera Italiana III, Facoltà di Teologia di Lugano.
Bibliografia
Letteratura
- Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino. Annuario di Storia Religiosa della Svizzera Italiana III, Facoltà di Teologia di Lugano.
- Trucco, N., Dehbi, A., Dziri, A., Schmid, H. (2025).. Il razzismo antimusulmano in Svizzera: studio di riferimento. SZIG/CSIS-Studies 12. Friborgo: Centro Svizzero Islam e Società.
Link
- Camplani, Barbara (05.04.2025). Islam invisibile. Le comunità musulmane nel contesto svizzero, RSI Moby Dick.
- Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC). Sito internet Geo-religions.ch, comprendente la Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino.
- Conferenza “Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino” del 27 febbraio 2025, Repubblica e Cantone Ticino.
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (stato 1° gennaio 2023).
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 3 marzo 2024).
- Dipartimento delle istituzioni (28.02.2025): “Successo della presentazione di Re:Spiri – Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino”. Comunicato stampa.
- Ufficio federale di statistica (UST). Religioni.
Per approfondire
Letteratura
- Afmataj, L. (anno accademico 2024-2025). Il ruolo delle associazioni islamiche in Svizzera. Le differenze religiose secondo la provenienza dei musulmani nel Canton Ticino. Tesi di Dottorato in Scienze Religiose. Facoltà di Teologia di Lugano.
- Trisconi, Michela. (2007). Repertorio delle religioni. Panorama religioso e spirituale del Cantone Ticino. Bellinzona: Dipartimento delle istituzioni